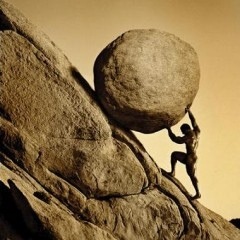Teresa Bertotti, assistente sociale e sociologa, ha lavorato per molti anni presso il CBM (Centro per il bambino maltrattato e cura della crisi famigliare) di Milano, si occupa di supervisione e formazione degli operatori, valutazione e progettazione dei servizi. È Dottore di ricerca e docente di Servizio sociale presso l’Università di Milano-Bicocca. Ha da poco pubblicato il volume “Bambini e famiglie in difficoltà. Teorie e metodi di intervento per assistenti sociali”, edizioni CarocciFaber.
Il dibattito sui “dati”, sviluppato anche durante il convegno promosso da Caritas e CNCA, sottolinea la necessità di condividere, tra servizi, una lettura e una interpretazione dei dati attraverso cui costruire anche strategie condivise di lavoro e di integrazione tra soggetti differenti che interagiscono negli interventi di tutela…
Oggi, in un tempo di risorse scarse, il tema dei dati è di grande rilevanza e attualità.
Ragionare sui dati significa, in primis, porsi una domanda: “che cosa contiamo, che cosa vogliamo misurare?” Possiamo misurare i costi del processo, quanto costa fare le cose, ma è anche possibile anzi auspicabile, trovare il modo per misurare il bisogno e capire quale è la domanda che non viene raccolta. In tal modo si potrebbe misurare l’esito. In questa fase questa i sembra la cosa più importante: dotarsi di buoni indicatori per misurare il bisogno, il benessere e il malessere di bambine e bambini.
In Lombardia assistiamo ad una ridondanza dei processi di standardizzazione, ad una spinta forte verso un managerialismo estremo per cui è tutto prestazione: i tentativi più o meno conclusi di raccogliere dati sugli interventi di tutela, sul numero dei bambini sottoposti a provvedimento del tribunale dei minorenni sono stati molti, ma dati sul bisogno ce ne sono pochi…
Credo sia invece possibile e necessario avviare un ragionamento più serio su come si misura il benessere dei bambini, facendo riferimento a chi, come Valerio Belotti per esempio, ha avviato insieme ad altri delle riflessioni importanti.
Altra area carente di dati, molto delicata, ma molto attuale, è il tema dei dati sull’efficacia degli interventi. Il dibattito sulla misurazione dell’efficacia degli interventi, attualmente, è caratterizzato da una dimensione ideologica molto consistente: l’impostazione delle evidence based practice è stata utilizzata per deprimere la professionalità degli operatori anziché usarla e potenziarla. Inoltre si trascura la complessità e la parzialità della misurazione delle ‘evidenze’: per decidere se un intervento è efficace e “serve”, il problema, nell’ambito dei minori e dell’infanzia, è prima di tutto esplicitare “a chi serve”, se deve servire ai bambini, ai genitori, alla collettività, al tribunale dei minorenni… L’efficacia è collegata al problema del benessere, bisognerebbe rimanere ancorati al fatto che lo scopo dei servizi per la tutela dei minori è legato all’incremento del benessere dei bambini e se non si misura il benessere non è possibile neanche misurare l’efficacia.
Un’ulteriore complessità è legata ai processi causali: come facciamo a dire che quell’intervento funziona o non funziona? In questo campo, non credo sia possibile stabilire tali nessi; si possono stabilire delle convergenze, delle multifattorialità, delle condizioni favorenti, ma non degli automatismi. Dalle esperienze in atto, inoltre l’esito è spesso legato al processo: ovvero al tipo di relazione che gli operatori instaurano con le persone.
A questo proposito, la ricerca, presentata anche nel libro, che va ad esplorare il tema dei cambiamenti nei servizi di tutela indica che laddove, nei servizi, sono stati introdotti dei processi di standardizzazione che hanno comportato anche la raccolta di dati, la raccolta dati è ben accetta quando è sostenibile nell’equilibrio complessivo del lavoro e quando permettere di rendere visibile il lavoro e di rendere visibile il bisogno e i risultati. In questi casi, un lavoro di raccolta di dati è percepito come contributo importante.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una evoluzione significativa dei rapporti tra servizi per la tutela e magistratura. A che punto siamo di questa relazione in via di definizione?
Mi sembra che oggi si sia compiuto il processo di distacco tra servizi e magistratura nel senso che la magistratura minorile che anni fa ha dichiarato che doveva essere più terza, effettivamente lo è diventata. Anche i servizi si sono resi più autonomi.
Il tutto però, nell’assenza più totale di una rielaborazione culturale di cosa questo abbia voluto e voglia dire, non c’è stato e continua a non esserci un processo di attribuzione di senso a quanto è accaduto e sta accadendo, specialmente nel quadro più ampio del dibattito sulle politiche.
Per quanto mi sembra di osservare, la Magistratura si è assunta il ruolo di non stare più dalla parte del bambino, ma dalla parte del diritto e quindi, viene meno la sua funzione di garante dell’infanzia. Interessante, perché è del 2011 l’istituzione del Garante dell’infanzia: forse una sapienza collettiva, intuitiva c’è, anche se il Garante dell’Infanzia non si occupa di questo, ma potenzialmente potrebbe farlo…
I servizi a loro volta potrebbero avere questo ruolo, ma non riescono ad averlo per due diversi motivi.
Da un lato, questo compito di garante, di protezione dei bambini non è attribuito ai servizi nel senso che non è detto, non è riconosciuto: la società non ha detto in questi anni che si vuole che ci sia qualcuno che si assuma la responsabilità di stare dalla parte dei bambini.
In alcuni paesi del Nord Europa per esempio, la legge stabilisce che alcuni servizi abbiano un’esplicita funzione di protezione e che quindi sono normati per quello, la Magistratura è di fatto un intervento di secondo livello a cui si accede solo le famiglie e i servizi non raggiungono un accordo. In Italia manca una legge quadro sulla tutela dell’infanzia, il ruolo dei servizi è molto eterogeneo: hanno nomi diversi e funzioni diverse; cercano di tenere insieme la funzione di protezione con la funzione di aiuto alla famiglia. Questo può essere un problema se non sono chiare le responsabilità.
Un altro motivo per cui i servizi faticano ad assumere questa funzione di protezione dei bambini è rintracciabile nell’idea oggi diffusa che i servizi debbano concentrarsi sulla prossimità e la cittadinanza e farsi protettori dei bambini significherebbe schierarsi per una parte ed essere parziali.
Oggi assistiamo ad alcuni movimenti che reinterrogano il mandato dei servizi di tutela: i giudici minorili sempre più spesso chiedono ai servizi di assumersi maggiori responsabilità (malgrado poi i giudici minorili ritardino a presentare i decreti ponendo un problema grave di diritti lesi…), così come i servizi, in alcuni luoghi, cercano di reimmaginarsi un modo per reinterpretare questa funzione di protezione..
Quale ruolo, per le famiglie, oggi negli interventi di tutela? Quali relazioni, quali strategie di lavoro con le famiglie? Da un lato si ribadisce la necessità di coinvolgere le famiglie, ma questo apre a tutta una serie di questioni, di competenze, di ruoli, di poteri… Cosa significa lavorare con le famiglie, al di là di assumerle come soggetti formali e portatrici di diritti…
C’è una confusione nel dibattito attuale intorno al tema della partecipazione della famiglia, tema che per altro va molto di moda.
Il tema della partecipazione delle famiglie è uno di quei temi, di quelle questioni il cui significato è fortemente connesso con il contesto in cui abitano.
Come la riflessione intorno all’empowerment: concetto che è stato al centro delle politiche neoliberali, malgrado fosse un concetto centrale presente alle origini dei servizi sociali… Il servizio sociale alla sua origine, postulava l’importanza di riconoscere la capacità di agire delle persone, di attivare risorse e competenze, ma se la parola empowerment la collochiamo dentro a una cornice che toglie risorse e non ci si interroga sul fatto che le persone in quella cornice non hanno risorse e potere per questioni strutturali, il rischio è un imbroglio.
Da un lato, negli anni si è corso certamente il rischio di scarsa valorizzazione delle competenze delle famiglie (legato alla gestione dei ruoli di potere…). Ma se parliamo oggi di coinvolgimento delle famiglie, dobbiamo cercare di capire dove sta l’imbroglio, dobbiamo chiederci quanto la nostra società è in grado di assumere l’esistenza di alcune fragilità e vulnerabilità che sono state prodotte, sono strutturale e non dipendono dal comportamento dei singoli, e su cui non bisogna imbrogliare la gente e tanto meno i bambini. Bisogna prestare molta attenzione a non abbandonare le famiglie in nome di una dichiarata autonomia che le famiglie non hanno e non riescono ad avere. È un problema di responsabilità sociale.
Il coinvolgimento delle famiglie oggi avviene più perché il tribunale ha deciso di applicare un certo metodo che non perché si ritiene che sia giusto e corretto. E gli esiti di questo coinvolgimento sono diversi. Per prima cosa, le decisioni nell’ambito del diritto minorile sono molto, ma molto più lente.
Altro effetto dirompente è l’aumento della dimensione di conflittualità, di contenzioso. Il coinvolgimento delle famiglie avrebbe avuto senso se fosse stato pensato all’interno di una alleanza sociale, di un patto sociale, mentre, di fatto, è avvenuto all’ombra di un pensiero sottointeso, implicito, che non viene detto, ma che è dirompente: dare alle famiglie più potere contro i servizi sociali che invece, negli anni, ne hanno avuto troppo. Questo è il non detto gravissimo che sottende al coinvolgimento delle famiglie.
Bisogna aggredire culturalmente il tema del contenzioso riorientando il problema, bisogna dirsi che il problema della tutela dei bambini e l’essere dei genitori inadeguati non è un problema solo della società, ma è un problema di quei genitori con cui diventa necessario stringere una alleanza. Deve cambiare il giudizio nei confronti dei genitori. Ho la sensazione che le scelte fatte dalla magistratura e l’aumentare della sua posizione terza non porti nella direzione auspicata.
Il dibattito intorno al coinvolgimento delle famiglie e al ruolo dei servizi introduce anche un altro dibattito importante, che ho cercato di affrontare nel libro, sul conflitto tra due etiche, l’etica della cura e l’etica del diritto. Oggi è importante guardare alla dimensione etica in modo laico.
Adottando un’etica della cura, dell’aver cura, si accetta che nella vita le persone abbiano dei momenti di fragilità e ci sia una solidarietà sociale che fa sì che ci si possa assumere l’altro nelle fragilità sapendo che la prossima volta capiterà a te.
L’etica del diritto prevede invece che le persone siano autonome, indipendenti, capaci di esprimere il loro desiderio, di essere razionali, di essere governatrici del loro destino e compito e funzione della società è dare la possibilità alle persone di esprimere i loro diritti.
Quello che è interessante per il nostro dibattito sugli interventi di tutela, è che queste due etiche devono essere compresenti nei servizi, ma non possono essere gestite insieme, non possono esistere in contemporanea. Il servizio in alcune fasi promuove un’etica della cura, in altre fasi un’etica dei diritti. Insomma, due etiche necessarie, ma che non possono essere utilizzate contemporaneamente, due approcci entrambi presenti nei servizi, ma non comunicanti.
Come è cambiato e come sta cambiando il lavoro di operatrici e operatori dei servizi per la tutela? Quale è l’impatto dei cambiamenti fin qui descritti nel lavoro di operatori ed operatrici?
Bisogna capire l’impatto di che cosa.
La carenza di risorse e la logica che si possano gestire i servizi introducendo logiche manageriali aumenta la standardizzazione e rende la questione molto delicata. È giusto capire quanto costano i servizi, ma se non si ha sufficiente sapienza nel capire fino a che punto bisogna andare a contare, allora si rischia di standardizzare molto ogni processo di lavoro e gli operatori rischiano di ritirarsi solo su una dimensione esecutiva, smettono di pensare, si astengono dal produrre una decisionalità che deve essere una decisionalità responsabile in un campo che non è standardizzabile.
I protocolli sono utili se sono delle linee guida.
Oggi credo sia necessario provare a proporre una separazione tra questioni gestionali e questioni tecniche: diverse ricerche ci dicono che la standardizzazione estrema non produce un risparmio, che tutto il processo complesso di esternalizzazione ed accreditamento in Lombardia sta generando dei costi di connessione, di rendicontazione altissimi. Gli assistenti sociali ci restituiscono una complessificazione estrema e disfunzionale dei processi di lavoro, ci raccontano che prima di parlare con l’educatore devono sentire il responsabile che a sua volta ha la responsabilità dei rapporti con la cooperativa che a sua volta deve rintracciare la persona… C’è tutta una catena talmente estenuante per cui alla fine non si seguono i protocolli e le procedure codificate, ma partono le relazioni informali che sono quelle che fanno funzionare le cose… Dobbiamo ridurre gli spazi di illusione per cui solo attraverso la standardizzazione si ottengono esiti…
La DGR IX/3850 del 25 Luglio 2012 introduce un contributo per le prestazioni a carattere sociosanitario in favore di minori vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento. Quali sono le tue riflessioni intorno a questa delibera?
La delibera in questione da un lato può essere letta come passaggio importante di riparazione dei danni generati dal ritiro della sanità dalle tematiche della tutela minorile.
È anche sicuramente giusto che vengano assegnati dei fondi ad attività psicologiche e psicoterapeutiche, ma c’è un presupposto nella delibera: il presupposto che i bambini in comunità abbiano più bisogno dei bambini che non sono in comunità, laddove per altro, non ci sono più soldi per esempio, per curare le famiglie.
Perché solo ai bambini in comunità?
I fondi inoltre, rappresentano il riconoscimento di diritti e bisogni a lungo termine o finiranno dopo un anno e non verranno più rinnovati?
Se dobbiamo immaginare che la delibera vuole essere è un impegno della Regione a fronte della valutazione dell’importanza degli interventi psicologici e psicoterapeutici, allora dovrebbe essere un intervento a sistema e sarebbe importante che ciò avvenisse perché ribadirebbe che la tutela minori non è solo una questione di tipo sociale o socio educativo.
Vedo anche un altro rischio nella delibera: se l’elargizione di fondi non si accompagna ad un monitoraggio stretto da parte dell’ente locale che ha la titolarità, il rischio è che i bambini stiano in comunità per più tempo. Mentre la misura dovrebbe avere lo scopo di aumentare il benessere, questo rischia che le comunità se li tengano… inoltre andrebbero verificate le modalità di controllo del loro nell’utilizzo. Qui forse si potrebbe inserire un buono studio sulla valutazione degli esiti.